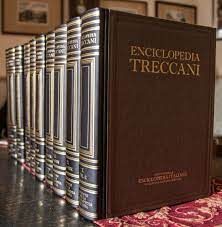AGI – Il 18 febbraio 1925 con la fondazione dell’Istituto Giovanni Treccani a Roma si ponevano le basi per la monumentale opera dedicata a scienza, arti e cultura
Nel primo dopoguerra, nel 1921, era stato costituito come ente morale l’Istituto per la Propaganda della Cultura Italiana, divenuto poi Fondazione Leonardo per la Cultura Italiana, che avrebbe voluto pubblicare la prima grande enciclopedia italiana in 18 volumi. Tre anni dopo, per sbloccare l’impegnativa impresa, si coinvolse nel progetto l’imprenditore di successo nel ramo tessile nonché mecenate delle arti Giovanni Treccani(1877-1961), che ne fu entusiasta. Pochi anni prima aveva effettuato un’ingente donazione all’Accademia dei Lincei e aveva acquistato la Bibbia di Borso d’Este per una cifra iperbolica, pur di evitare che potesse finire in Francia. Era senatore del Regno dal 1924 e raccolse subito l’invito. E così a Roma veniva fondato l’Istituto che portava il suo nome, per poter organizzare l’immensa mole di lavoro, di studio e di compilazione. Tra i fondatori, e primo direttore scientifico, c’era il filosofo Giovanni Gentile, già ministro dell’educazione. Tra le altre personalità coinvolte, il Maresciallo d’Italia Luigi Cadorna e l’ammiraglio Paolo Thaon de Revel, gli storiografi Gaetano De Sanctis e Francesco Salata, gli economisti Luigi Einaudi e Angelo Sraffa, il pittore Vittorio Grassi, il medico Ettore Marchiafava, il giurista Silvio Longhi, il giornalista Ugo Ojetti, il presidente del Senato Tommaso Tittoni. A guidare la redazione, il filosofo Antonino Pagliaro.
Le insidie del regime e lo specchio dei tempi
Se è vero che molti dei collaboratori subito chiamati a far nascere il progetto aderiranno il 21 aprile 1925 al Manifesto degli intellettuali fascisti, è anche vero che l’Enciclopedia riuscì a coinvolgere oltre 3.200 intellettuali italiani di alto livello e riconosciuto profilo, di qualsiasi orientamento politico, anche ebrei e persino antifascisti dichiarati. Per quanto possibile le ingerenze del regime furono limitate o tenute al di fuori. Naturalmente, essendo figlia dei tempi, l’Enciclopedia non poté essere immune né da contaminazioni né da infiltrazioni. La voce “Fascismo”, a esempio, si diceva fosse stata elaborata da Benito Mussolini in persona, ma sembra assai più veritiero che l’abbia scritta lo stesso Gentile che volle l’opera come summa della cultura italiana in tutte le sue declinazioni.
Tre anni di lavoro per vedere il primo di 35 volumi
Occorsero tre anni per coordinare il funzionamento di ben 48 sezioni di studio e scandire le oltre sessantamila voci che avrebbero costituito il corpo della prima edizione. Il primo dei 35 volumi (da A-Agri a Veg-Zyg, ognuno dei quali di un migliaio di pagine di media) apparirà nel 1929 e l’ultimo, assieme all’indice dei nomi, nel 1937. Il risultato complessivo dell’Enciclopedia italiana ne farà ben presto uno dei più pregevoli e importanti prodotti editoriali del XX secolo, e certamente il principale su scala nazionale. Il grande successo non deve avere a riferimento la platea dei lettori, poiché si trattava di un’opera costosa, prestigiosa e d’élite, che però trovava la sua dimensione più popolare grazie alle varie biblioteche che la mettevano a disposizione degli studenti, dei ricercatori e di chiunque desiderasse acculturarsi ma non poteva permettersi di avere una Treccani sugli scaffali della libreria di casa.
Verso la modernità e la diffusione sulle vie del web
Nel secondo dopoguerra verranno pubblicate a scansioni temporali irregolari le appendici, e come accadeva per i beni di consumo nel boom economico si lanciò l’acquisto rateale, per allagare quanto più possibile i fruitori di un’opera tutt’altro che economica, il cui importo finale veniva diluito in piccole quote mensili. Alla fine del primo decennio del XXI secolo, anche la Treccani si dimostrava al passo con i tempi, proponendo l’innovazione tecnologica del dvd che semplificava le procedure di consultazione abbreviando considerevolmente i tempi. Ma ancora prima, alla fine del Millennio, grazie alla creazione del sito internet Treccani, era diventata possibile la consultazione on line. Quota cento milioni annui di accessi è stata superata per la prima volta nel 2014. Da cento anni lo scibile umano vive nella lingua di Dante, perpetuandosi e innovandosi dalle pagine cartacee ai pixel sugli schermi dei computer, dei tablet e degli smartphone.
 Stampa questa notizia
Stampa questa notizia